Disturbi specifici dell’apprendimento: una guida per genitori tra realtà e luoghi comuni

Negli ultimi anni è sempre più frequente sentir parlare di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), nonostante questa tematica sia ancora avvolta da dubbi, pregiudizi e informazioni confuse.
Eppure, i dati parlano chiaro: secondo il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’anno scolastico 2022/2023 il 6% degli studenti dalla terza primaria alla secondaria di secondo grado aveva una certificazione DSA.
Per questo motivo, questo articolo cercherà di rispondere alle principali domande che i genitori si pongono, tentando di offrire una guida pratica e chiara per orientarsi meglio.
Tale guida non pretende di essere esaustiva, ma intende fornire una prima panoramica sulle questioni più frequentemente dibattutte riguardo a questo tema.
1. Cosa sono i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)?
I Disturbi Specifici dell’Apprendimento sono “difficoltà di apprendimento e nell’uso di abilità scolastiche” che “iniziano durante gli anni scolastici” e “causano significativa interferenza con il rendimento scolastico o lavorativo”(DSM-5)
La Legge 170/2010 riconosce diversi sottotipi di disturbi che possono essere presenti isolatamente o contemporaneamente (si parla in questo caso di “comorbilità”):
- Dislessia: la difficoltà riguarda la lettura, caratterizzata da minore correttezza e rapidità rispetto a quanto atteso
- Disgrafia e disortografia: la difficoltà è relativa alla scrittura, ma riguarda componenti diverse. Nella disgrafia sono presenti difficoltà riguardanti gli aspetti grafici della scrittura a mano, mentre nella disortografia la difficoltà riguarda la conversione dei suoni in simboli grafici, cioè l’applicazione delle regole ortografiche.
- Discalculia: difficoltà relativa al calcolo, al recupero dei fatti numerici (es. tabelline), al ragionamento matematico.
Queste difficoltà non riguardano una totale incapacità nell’eseguire compiti di lettura, scrittura e/o calcolo, ma piuttosto nel riuscire a rendere tali procedure automatiche (quindi veloci ed accurate).
2. La dislessia è un problema di intelligenza?
Nessuno dei diversi sottotipi di DSA è un “problema di intelligenza”.
Anzi, per poter effettuare diagnosi di DSA, è necessario che NON siano presenti
- Disabilità intellettive (QI< 70)
- Problemi neurologici e/o sensoriali
- Svantaggio socio-culturale e mancanza di adeguate opportunità educative
3. Si può “guarire” dai DSA?
I Disturbi Specifici dell’Apprendimento non sono una malattia, ma una neurodiversità: derivano da una modalità diversa di funzionamento di tutti quei processi cerebrali implicati nella lettura, scrittura e calcolo.
Per questo motivo, i DSA non possono essere del tutto risolti, ma possono essere efficacemente compensati grazie a una diagnosi precoce e all’avvio di percorsi di riabilitazione, potenziamento e tutoraggio.
4. I DSA possono derivare da pigrizia/demotivazione/scarso impegno di mio figlio?
No, al contrario di quanto molto spesso si crede, i Disturbi Specifici dell’Apprendimento non possono derivare da pigrizia, demotivazione o scarso impegno.
La loro origine è neurobiologica e non dipende dalla “volontà” della persona.
Sono da tenere in considerazione, però, gli effetti che questi disturbi, se non riconosciuti e non compensati, possono avere a livello emotivo, psicologico e motivazionale.
Tali disturbi, infatti, hanno un forte impatto sulla vita scolastica dei bambini/ragazzi, un’area centrale durante lo sviluppo. Se non adeguatamente sostenuti e compensati attraverso percorsi personalizzati, i DSA possono comportare esperienze di apprendimento negative ed andare ad influenzare l’autostima, il senso di autoefficacia e il concetto di sé, diventando un importante fattore di rischio per l’abbandono scolastico.
5. Come avviene la diagnosi?
La diagnosi può essere effettuata a partire dalla fine della seconda classe della scuola primaria per dislessia, disgrafia e disortografia e dalla fine della terza classe della scuola primaria per discalculia, a seguito di persistenti difficoltà nonostante interventi di recupero didattico mirato.
La diagnosi può essere rilasciata anche da privati, ma per ottenere una certificazione di DSA valida a livello legale per accedere alle misure previste dalla normativa vigente, è necessario rivolgersi al Sistema Sanitario Nazionale o a strutture private accreditate o convenzionate.
La diagnosi viene effettuata da un’equipe multidisciplinare composta da professionisti quali neuropsichiatra infantile, psicologo e logopedista.
E’ necessario comunque fare riferimento alle normative della propria regione di appartenenza.
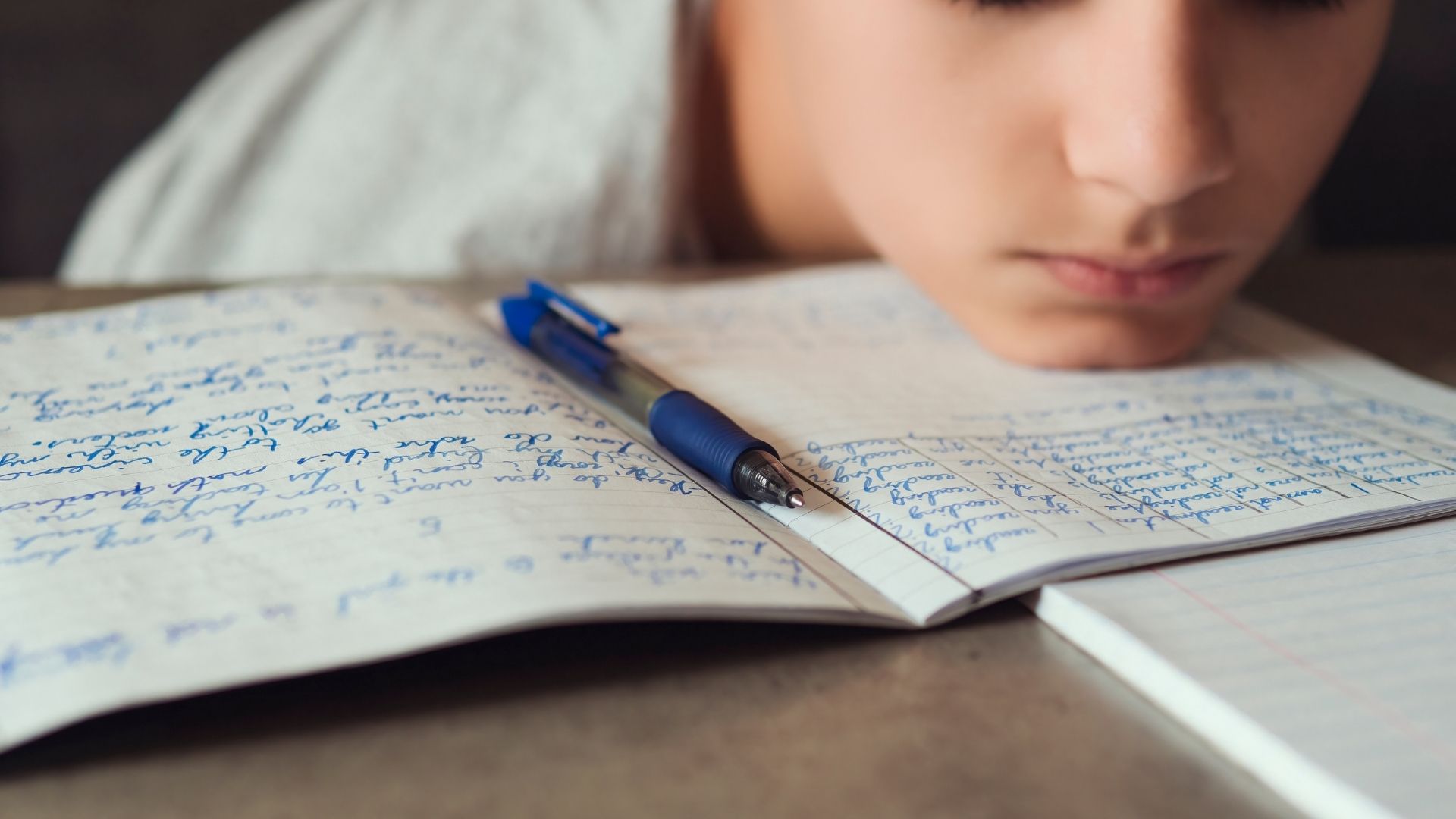
6. Quali procedure/strumenti vengono adattati a livello scolastico per chi ha una diagnosi di DSA?
Come definito dalla Legge 170/2010, devono essere garantiti agli studenti con DSA una serie di misure, tra le quali:
- Una didattica individualizzata e personalizzata
- Utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative
- Adeguate forme di verifica e di valutazione
Per queste finalità, il Consiglio di Classe è tenuto a compilare il Piano Didattico Personalizzato (PDP), un documento mirato a definire un percorso didattico personalizzato e individualizzato, aggiornabile durante l’anno e da predisporre entro il primo trimestre di scuola.
Il PDP deve essere condiviso con la famiglia prima di essere approvato, in quanto rappresenta un accordo tra scuola, famiglia e figure socio-sanitarie.
7. Sono previste misure/agevolazioni per i familiari?
Sì, sono previste delle misure per i familiari. Tra le principali abbiamo:
- Orari di lavoro flessibili: “i familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell’istruzione con DSA impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili” (Legge 170/2010)
- Indennità di frequenza: beneficio finanziario regolamentato dalla legge 289/1990
A cura della Dott.ssa Elisa Morelli – Psicologa


